Chiesa Madonna del SS. Rosario
Le origini della chiesa della Madonna del Rosario affondano le radici nel XVI secolo. Inizialmente dedicata a San Vittorino, la sua trasformazione in un raffinato esempio di architettura barocca avvenne tra il 1602 e il 1680. Fu il chierico Placido Nolfi a promuovere la ricostruzione iniziale, ma fu il conte Giovanni Battista de Sangro a imprimere un segno indelebile, arricchendo la chiesa con l’altare maggiore e numerosi ornamenti.
Fonti storiche, tra cui la relazione del vescovo Cavalieri (1629), scritti di Ludovico Antonio Antinori e testimonianze parrocchiali di Paolo Colarossi (1929) e Francesco De Panphilis (1938), raccontano una storia articolata fatta di ampliamenti, restauri e resistenza ai numerosi terremoti che colpirono l’Abruzzo nei secoli XVII e XVIII.
Nonostante le ferite inflitte dai sismi e dai conflitti (tra cui i danni arrecati da un blindato tedesco durante la Seconda guerra mondiale), la chiesa ha saputo conservare la propria identità. Restaurata in varie fasi nel XX secolo — culminate nel restauro definitivo del 2000 — oggi la chiesa si presenta come un fulgido esempio di arte sacra barocca abruzzese.
La chiesa si affaccia sulla piazza principale del paese in una posizione centrale ma discreta. La facciata, semplice con composizione simmetrica organizzata su due livelli principali divisi da una cornice marcapiano, riflette una sobrietà tipicamente cinquecentesca. La parte inferiore è in pietra a conci regolari, quella superiore è intonacata e sormontata da un cornicione.
Il portale principale, lineare, è impreziosito da figure antropomorfe in bassorilievo e dallo stemma della famiglia de Sangro. Un’edicola sopraelevata ospita la statua di San Rocco, protettore invocato contro la peste. Un tempo la chiesa era dotata di un campanile più alto, crollato nel terremoto del 1915 e poi ricostruito in forma più modesta.
Oltrepassata la soglia, l’interno della chiesa sorprende per la ricchezza decorativa e la teatralità barocca. A navata unica, con otto cappelle laterali, l’edificio presenta una volta a botte affrescata, murature in pietra e una volta in tufo. L’illuminazione è garantita da sette finestre che creano giochi di luce sulle superfici ornate da stucchi e affreschi.
Il vero protagonista è l’altare maggiore, autentico capolavoro scenografico ispirato al "modus berniniano". Realizzato in materiali lapidei, marmo e stucchi traforati, è articolato in tre ordini. Vi si trovano statue di santi, putti e angeli in gloria, e una luce indiretta che richiama la Cattedra di San Pietro a Roma.
Un elemento raro e di grande fascino è la presenza di statue a grandezza naturale sui pilastri rivolti verso l’aula: santi scolpiti in stucco che sembrano dialogare con i fedeli. Questa caratteristica, inusuale per l’Abruzzo, ha fatto ipotizzare l’intervento di artisti lombardi, forse legati alle botteghe attive in area milanese e coinvolti in numerosi cantieri lungo la via del Sagittario.
La devozione al Rosario, introdotta in Abruzzo dai Domenicani, trova nella chiesa di Bugnara una delle sue espressioni più compiute. All'altare maggiore si trovano infatti le statue di San Domenico e Santa Caterina da Siena, testimoni di una fede profondamente radicata nella comunità locale.
Nel 1743 fu istituita la Confraternita del Rosario, che ebbe un ruolo importante nella vita religiosa e sociale del paese.
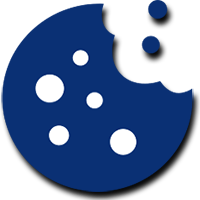












 per installare la App sul tuo
per installare la App sul tuo
